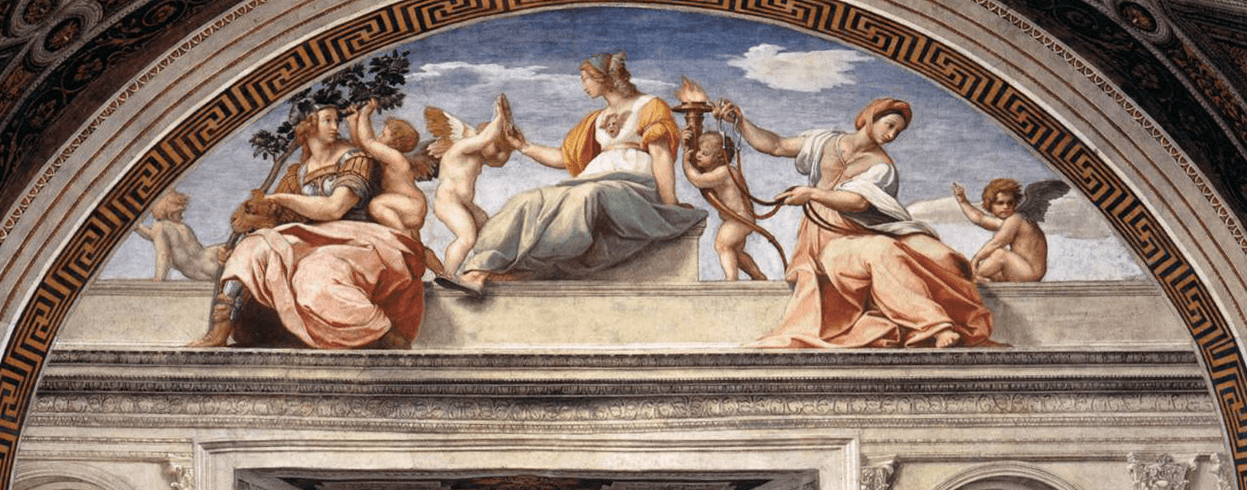Si può dire che Giulia fosse “figlia d’arte”, in quanto sembra che sua madre, o sua nonna, fosse Thofania d’Adamo, giustiziata per aver eliminato il marito “cum venificio propinato”.
Rispetto alla d’Adamo, Giulia aveva raffinato la tecnica di preparazione del veleno: grazie a una particolare procedura di ebollizione dell’anidride arseniosa, era riuscita a ottenere una soluzione altamente tossica a base di sale d’arsenico, la quale si presentava come una semplice acqua, del tutto inodore e insapore, quindi, somministrabile alla vittima designata con estrema facilità.
Dietro alla facciata di cortigiana d’alto bordo e fattucchiera, Giulia aveva avviato una fiorente attività basata sulla produzione e vendita della sua “soluzione”: come una vera donna d’affari, aveva provveduto anche al “packaging” del prodotto, che presentava in fiaschette di vetro di circa mezzo litro, costose ma non economicamente inaccessibili.
Venivano dettagliatamente fornite le corrette istruzioni d’uso: si dovevano somministrare poche gocce al giorno, tempo due settimane il risultato era garantito: la morte veniva scambiata per una forte gastroenterite, malattia all’epoca largamente diffusa, così tutti la facevano franca.
L’acqua Tofana era diventata il rimedio ideale per procedere a un “divorzio” rapido e senza le lungaggini giudiziarie che ben conosciamo, per eliminare le amanti che infestavano la felicità coniugale, oppure per portare a termine piani che prevedevano la morte del malcapitato di turno, come nel caso di successioni ereditarie maturate prima del termine naturale… poco importava che si trattasse di un parente, un fratello o un amico.
Giulia, grazie al suo lavoro, era diventata molto ricca e nessuno sospettava nulla, sino al giorno in cui vendette la sua acqua a un tale di nome Spadafora il quale, invece di seguire le istruzioni d’uso, propinò alla vittima tutto il contenuto della fiaschetta, facendolo morire in tempi brevissimi e con evidenti sintomi di veneficio.
Giulia era ben consapevole che in breve le indagini sarebbero arrivate a lei, per cui decise di lasciare Palermo immediatamente: destinazione Roma.
Dopo diverse traversie, giunse nella Città Eterna dove, in poco tempo e con le conoscenze giuste ottenute grazie alla sua “professione”, riavviò la sua redditizia attività commerciale.
Le sue clienti erano prevalentemente donne che non riuscivano a disfarsi dei mariti, per cui ricorrevano al drastico metodo dell’acqua Tofana: tale pratica delittuosa venne scoperta quando una di loro somministrò il veleno in dosi eccessive. La donna sottoposta a tortura rivelò che il preparato era stato prodotto e venduto da Giulia Tofana.
Fermo restando che all’epoca i Tribunali non andavano tanto per il sottile, anche oggi possiamo sostenere come la posizione della cortigiana fosse difficilmente difendibile dall’accusa di concorso nel reato di omicidio volontario.
Il concorso si perfeziona quando il crimine è il risultato della consapevole partecipazione di ciascun concorrente alla determinazione dell’evento criminoso: in altre parole, ogni soggetto agente deve aver volontariamente fornito il proprio contributo personale alla realizzazione del delitto.
Nel caso di specie, Giulia Tofana è stata una complice dell’autrice materiale del delitto: infatti, se è vero che la sua partecipazione al reato si è limitata alla fornitura del veleno – materialmente somministrato dalla moglie della vittima – è altrettanto pacifico che tale contributo causale si sia rivelato determinante per l’omicidio. Sotto il profilo sanzionatorio tutti i correi soggiacciono alla pena prevista il reato commesso.
Le cronache dell’epoca non raccontano di un processo penale a carico di Giulia Tofana e sembra che la sua morte sia sopravvenuta per cause naturali.
Non morì, invece, il segreto della sua “acqua”, che venne tramandato alla sua figliastra Girolama Spana, la quale continuò e sviluppò l’attività della matrigna insieme ad altre quattro donne. Le cinque “imprenditrici” vennero fermate soltanto dopo diversi anni: il processo destò grande scalpore, il numero dei decessi era da capogiro, pare che le vittime complessive fossero più di 600. Il Tribunale ritenne le cinque avvelenatrici tutte penalmente responsabili dei reati loro ascritti, condannandole alla pena capitale che poco dopo venne eseguita in Campo dei Fiori a Roma.
Giulia, l’acqua… e il concorso nel delitto quasi perfetto.

Per approfondire:
“Veleni Intrighi e Delitti nei secoli” di F. Mari e E. Bertol, ed. Le lettere 2003;
“Diritto Penale – Parte Generale” di F. Fiandaca – E. Musco Sesta edizione ed. Zanichelli 2014